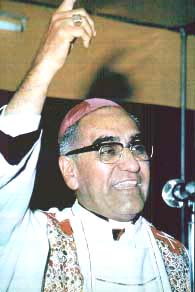|
Sentire
cum Ecclesia, il ministero episcopale di O. A. Romero
di
Abramo Levi
Sono
trascorsi ormai vent'anni dall'assassinio brutale e clamoroso
del vescovo di San Salvador O.A. Romero. La distanza temporale
ed emoti-va dell'evento permette una riflessione più pacata
sul senso del suo ministero episcopale, condotto con coraggio
e forza fino a quella morte, le cui circostanze - sull'altare,
al momento dell'Offertorio - sono simbo-licamente tanto dense.
Assassinio
sull'altare
A
fermare l'occhio della nostra memoria sugli avvenimenti che culmi-narono
la sera del 24 marzo 1980 con l'assassinio del vescovo Oscar Arnulfo
Romero, nella Cappella dell'Ospedale Divina Provvidenza in San
Salvador, c'è quella messa non finita, e il sangue vivo
del celebrante versato sull'altare.
Non c'è solo da ricordare un 'assassinio nella cattedrale',
dopo circa novecento anni da quello famoso. C'è altresì
da superare uno scarto di anni, esilissimo a confronto - venti
appena - ma già molti e forse troppi per la labilità
della nostra memoria. L'assassinio del vescovo Romero non si presta
all'enfasi (storica o letteraria) dell'assas-sinio nella Cattedrale
del vescovo Becket, ma in compenso ha qualche cosa di molto più
puntuale e preciso nello spazio e nel tempo: sull'altare e al
momento dell'offertorio della Messa.
Ne
rilevò l'aspetto inedito e costrittivo p. Turoldo:
"Amico, qui ti devi fermare. E medita, e rileggi... E' Dio
che vuoi farsi capire. Non lo ha colto (il vescovo Romero) per
una strada; si potrebbe dire: non fosse passato per quella strada!
Non lo ha colto in un salotto: uno potrebbe dire: non fosse andato
in quel salotto!... Invece l'ha colto mentre celebrava. E stava
con il calice in mano. E aveva appena detto che in quel calice
c'era del vino in attesa di farsi sangue"1.
Fermiamoci
dunque. La pregnanza del modulo evangelico ci obbliga ad adottare,
per intenderlo, il modello tradizionale di riflessione con i suoi
due tempi: Factum audivimus mysterium requiramus. Ecco il fatto.
Dopo l'omelia del 23 marzo nella quale mons. Romero pregò
e ordinò ai soldati di non uccidere, il colonnello Marco
Aurelio Gonza-les disse: "L'Arcivescovo ha commesso un delitto,
gettando il disprez-zo sul nostro glorioso esercito". La
sera del 24 marzo alle 18.30 nella cappella della Divina Provvidenza
Monsignore terminò la sua breve omelia. Prese il corporale
per stenderlo sull'altare. In quell'attimo si udì uno sparo
e Romero cadde di schianto. Il colpo venne dal lato occidentale
della Cappella dell'Ospedale, dove l'Arcivescovo risiede-va con
i più poveri e abbandonati. Il proiettile penetrò
all'altezza del cuore, senza però toccarlo. Era un proiettile
esplosivo. Provocò una emorragia diffusa. Il colpo fu preceduto
da tre flash del fotografo che si era installato sul pulpito.
Al terzo flash il colpo, che a molti parve lo scoppio di una lampadina.
Passato il primo momento di stupore, alcune religiose ed altre
persone cercarono di aiutarlo. Madre Juanita prese in grembo la
testa di Monsignore e gli levò la stola dal collo. La città
fu tutta confusione. Scemarono i trasporti pubblici, si chiusero
ristoranti e negozi.
L'Arcivescovo fu deposto in un feretro metallico di color grigio
a un paio di metri dal pulpito della Cattedrale, luogo che diventò
famoso in tutto il mondo per le vigorose denunce che mons. Romero
lanciò negli ultimi anni con inusitato rigore contro coloro
che violano i diritti umani in questa piccola nazione centro-americana.
All'interno della Cattedrale, dietro l'altare, un gruppo di 22
tra sacerdoti, religio-se e seminaristi fanno un digiuno completo
fino al momento della sepoltura dell'Arcivescovo. Il digiuno e
la preghiera sono la maniera con cui il popolo di Dio mostra il
suo desiderio di cambiamento in momenti estremi. Questo dunque
il fatto. A cui si può aggiungere la testimonianza di un
altro fedele: un'ora prima della Messa l'Arcive-scovo si recò
a S. Tecla per confessarsi, come era solito fare ogni settimana.
Il
mysterium della morte di Romero
Prima
di passare al secondo momento, mysterium requiramus, c'è
da rispondere a un'obiezione, che si può sbrigativamente
formulare così:
"Qui di mistero non ce n'è. Qui c'è soltanto
il fatto di un vescovo che si è sbilanciato un po' troppo
a sinistra, con tutte le buone intenzioni - ovviamente - e con
una buona dose di ingenuità, così da provocare per
una sorta di reazione uguale e contraria la sua eliminazione fisica".
Io penso che questa sarà stata e sarà, nei dovuti
modi e forme, l'obiezione che l'avvocato del diavolo solleverà
nel processo di beati-ficazione. E penso anche che il postulatore
della causa farà notare a sua volta che la reazione fu
per ogni verso eccessiva e non certamente uguale. E tuttavia c'è
ragione di parlare di mistero. E i primi ad avvertirne l'aura
furono i più alti rappresentanti della gerarchia du-rante
le esequie dell'Arcivescovo.
Il card. Corripio, rappresentante del Papa, disse: La Chiesa universale
celebra oggi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E mentre
alcuni stendevano sul suo cammino i mantelli e agitavano rami
di palma, altri sconcertati, si domandavano: - Chi è costui?
Oggi la città di San Salvador fa la stessa domanda per
mons. Romero: - Chi è costui? E noi che lo conosciamo,
rispondiamo: - E' un Pastore che ubbidì fino all'ultimo
ai dettami della sua coscienza.
A
sua volta il Vicario capitolare, mons. Urioste diceva: Siamo come
cristiani il giorno della Pentecoste, parliamo varie lingue, riceviamo
telegrammi che ci riesce difficile tradurre. Il fatto è
che gli uomini di buona volontà di tutto il mondo sono
riuniti in questa Catte-drale di San Salvador, perché crediamo
che mons. Romero è vivo e crediamo pure che il suo spirito,
che è lo spirito di Gesù, rinasce in ciascuno di
noi.
Accanto
a queste voci alte c'è il sottovoce di testimonianze umilissime,
ma ancor meglio intonate al modulo evangelico, fin quasi a coincidere.
Una di queste venne segnalata dal Vescovo ausiliare di Madrid,
mons. Iniesta.
Una
mattina andai a baciare quelle suppellettili sacre e consacrate
da quella morte. Nel chinarmi vidi sotto l'altare una corona di
spine. Ne chiesi conto alla religiosa dell'Ospedale che mi accompagnava.
Mi rac-contò un grazioso episodio praticamente sconosciuto
in San Salvador. Una vecchietta salvadoregna veniva di quando
in quando, da molto lontano, ad ascoltare la messa mattutina dell'Arcivescovo,
poi si intratte-neva qualche po' con lui e gli offriva frutti,
portati da lei stessa. Un giorno, l'ultima volta che venne a vederlo,
già parecchi mesi fa, gli portò come sempre della
frutta che gli consegnò al finire della Messa. Questa volta
però gli portò un crocifisso che gli pose al collo
e una corona di spine presa da una pianta chiamata izcanal con
spine di due o tre centime-tri e chiese di mettergliela sulla
testa. Monsignor Romero accettò, e mentre l'Arcivescovo
teneva la corona di spine in testa e il crocifisso al petto, lo
benedisse.
Questo
episodio fa pensare all'unzione di Maria di Betania, con quel
tanto di diverso che ne assicura l'autenticità eliminando
qualsiasi forma di attrazione analogica. C'è la medesima
grazia nella risposta che il vescovo Romero diede alle Suore che
lo guardavano con una certa invidia, quella mattina del 24 marzo,
recarsi al mare per riposare e bagnare i piedi nel mare: "Dove
vado io, voi non potete venire!". Cosa avranno detto le Suore
quella sera?
La
conversione
Noi
non possiamo far nostra la certezza della presenza di un mistero
reale quale vi fu nella vecchietta della corona di spine o nelle
religiose che udirono quella citazione evangelica, così
verde di speranza alla mattina e così rossa di sangue la
sera. Per il mistero del vescovo Romero noi abbiamo un'altra possibilità:
quella di declinarlo sul para-digma della 'conversione'. Questa
declinazione è alla nostra portata. Tramite essa noi possiamo
avvicinarci in maniera convincente alla reale vita, passione e
morte di mons. Romero. Ma la conversione del vescovo Romero deve
essere a sua volta analizzata per non rischiare di cadere in belle
approssimazioni drammatiche.
Non c'è paragone tra questa conversione e quella, per citare
episo-di famosi, di un Saulo o di un Agostino.
Iniziamo con una doppia domanda: Come fu vista da fuori la conversione
di Romero? Come fu vissuta da lui stesso? Per la prima domanda
abbiamo una testimonianza preziosa: quella di Jon Sobrino, il
gesuita che, solo per essere in quel torno di tempo assente (si
trovava in Thailandia), sfuggì al massacro dei gesuiti
dell'Università Centro Americana (UCA) perpetrato dagli
squadroni della morte nel novem-bre 1989. Ebbene, cosa pensava
J. Sobrino di mons. Romero al tempo dell'ingresso in San Salvador
come Arcivescovo? Ascoltiamolo:
"È
evidente che non vedevamo di buon occhio che mons. Romero fosse
il successore dell'arcivescovo Luis Chavez, vescovo pastorale
molto vicino al popolo e con cui avevamo buonissimi rapporti...
Mi chiedevo se mons. Romero aveva il coraggio di denunciare la
repressione o se, al contrario, la voleva facilitare. Pochi giorni
dopo ricevetti una cartolina postale da un gesuita messicano la
quale per poco non mi faceva le condoglianze. Noi tutti vedevamo
un orizzonte molto scuro. Per fortuna, ci sbagliammo".
Ecco
invece la testimonianza dello stesso Sobrino dopo l'assassinio
dei gesuiti, a dieci anni dalla morte di Romero:
Voglio
dire invece qualche cosa su ciò di cui, con frequenza,
parlavamo di Monsignor Romero. Quello era linguaggio di fede.
Voler bene e ammirare Monsignor Romero non è una cosa difficile
in assoluto; lo è magari per quelli che negano la luce
e hanno un cuore di pietra, ma cercar di seguire e accettare tutto
Monsignor Romero è cosa di fede. Io credo che per loro,
(i gesuiti uccisi, n.d.r.), per me e per tanti altri, Monsignor
Romero fu un Cristo attualizzato e, come Cristo, sacramento di
Dio... Non credo che né il Signore Gesù né
il Padre siano gelosi che io parli così di Monsignor Romero.
Dopo tutto, lui è stato per noi tutti il loro dono più
prezioso in questi giorni.
La
conversione di mons. Romero è dunque da collocare nella
cornice di queste due testimonianze, almeno per quel che riguarda
la conver-sione vista da fuori. Ma è ormai tempo che cerchiamo
quel che è più difficile trovare, cioè come
la conversione fu vista e vissuta dallo stesso Vescovo. Non pretendiamo
di sapere come Romero vide la propria conversione. Possiamo invece
conoscere come la proiettava fuori di sé. Cosa che fece
in un'intervista del 9 novembre 1979 a Giorgio Callegari che chiedeva:
"Ma Lei si è convertito davvero?". Mons. Romero
rispose con molta vivacità:
"Magari
mi fossi convertito! La conversione è sempre verso Dio,
e il povero è precisamente un testimone di questa necessità
dell'intervento di Dio. Trattando con il povero si capisce che
egli è un uomo che deve porre tutta la sua fiducia in un
altro. Se quest'altro è Dio, si ha la vera conver-sione,
perché si può altresì porre la fiducia nell'idolo
del potere, della ricchezza. Convertirsi significa volgersi al
Dio vivo e vero e in questo senso lo sento che il mio contatto
con i poveri conduce a sentire sempre meglio la necessità
di Dio. L'esempio del povero che scopre al di là di un
certo complesso di inferiorità di essere prediletto da
Dio e che quanto più è privo di idoli terrestri
tanto più conta sulla protezione di Dio e pone in Dio la
speranza della sua liberazione insegna a tutti, anche a noi che
lo predichiamo, che senza Dio non possiamo far nulla".
Il
testo di questa intervista ci servirà per indovinare come
fu vissuta la conversione da parte del vescovo Romero. Dico indovinare,
perché potrà accadere che nel vissuto quotidiano
del Vescovo non si riesca a trovare qualche cosa di simile a una
conversione quale noi immaginia-mo, con esorcismo sulla vita passata,
con propositi di completo rinno-vamento, con preghiere e astinenze,
con una scelta di povertà volonta-ria. Niente di tutto
questo nella conversione del vescovo Romero. Porto un solo esempio
a riprova.
Nell'occasione dell'ingresso dell'Arcivescovo a San Salvador (se
ne è già trattato) alcune signore della aristocrazia
salvadoregna avevano avanzato la proposta della costruzione di
una nuova sede episcopale degna dell'alto ministero: "Volentieri
accetterò questa casa - rispose l'Arcivescovo - quando
tutti i poveri che abitano nei barrios della miseria avranno una
casa". Non c'è nulla in questa risposta che risenta
di quel pauperismo (sempre un po' ambiguo) che spesso connota
delle scelte radicali. L'Arcivescovo non è contrario a
una bella resi-denza, ma che non stoni con la miseria degli altri,
come stona l'illumi-nazione notturna di certe chiese e monumenti
che schiacciano ancor più nel buio le altre abitazioni.
Sentire
con la Chiesa
Difficile
dunque isolare questa conversione, che si realizza, si direbbe,
nell'identico. Infatti i termini reali della conversione, il suo
statuto e le sue esigenze sono già inscritte come in una
sorta di codice genetico nel motto che il Vescovo scelse per il
suo stemma e che poi adottò anche come sigla per la sua
radio Isax: "Sentire cum Ecclesia". Se andiamo a rileggere
l'intervista non facciamo certo fatica a rintracciarvi termini
come 'sentire', 'senso', 'sento'. Si può ben dire che la
storia della conversione di Romero è la storia di questo
'sentire' che determina poi il modo di guardare alla Chiesa, di
vederla, di ascoltarla.
In un primo tempo il "Sentire cum Ecclesia" fu inteso
da Monsignor Romero nel senso più ovvio ed elementare,
scolastico. È il senso di tutto ciò che nella vita
è propedeutico, preparatorio. Il sapere quel che si deve
fare e l'eseguirlo secondo l'ordine ricevuto fa parte della propedeutica
della vita. A questo proposito il vescovo Romero rac-contava un
particolare della sua fanciullezza. La famiglia Romero si poteva
classificare come una famiglia agiata (anche se non appartene-va
alle famose 14 famiglie detentrici della maggior parte delle proprie-tà
in Salvador). Piccolo emblema di questa agiatezza era un cavallino
di legno regalato in qualche occasione al piccolo Oscar. Quando
la mamma mandava il figlioletto per qualche servizio e voleva
una obbe-dienza pronta e gioiosa, gli diceva: "Monta sul
tuo cavallino e va'!". E Oscar, docile, saliva sul suo 'ippogrifo'
e si metteva al galoppo, andata e ritorno.
Questo episodio mi sembra illuminante per capire quale senso abbia
avuto in quel primo tempo il motto "Sentire cum Ecclesia".
Esso significò per il Vescovo un'adesione intelligente,
incondizionata, gio-iosa alla dottrina della Chiesa, al suo magistero,
alle sue direttive. Un passaggio limpido e senza riserve dall'obbedienza
alla madre all'obbe-dienza alla madre Chiesa. Perfino il cavallino
ha qui il suo simbolismo. Mons. Romero fin dall'inizio del suo
ministero tenne molto all'uso di tutti i mezzi di comunicazione
forniti dal progresso tecnico: la stazio-ne radio diocesana, l'altoparlante
montato sulla camionetta che lo tra-sportava nella visita alle
parrocchie. Romero non era certo un laudator temporis acti. Fin
da giovane prete aveva preso ad amare la sua fotocopiatrice e
il suo computer, magari in un'edizione rudimentale.
Il motto "Sentire cum Ecclesia" aveva dunque un suo
significato chiaro. Tra consenso e dissenso egli si collocava
senza il minimo di esitazione dalla parte del consenso; e non
risparmiava dure strigliate ai 'medellinisti', tra i quali in
prima fila i teologi dell'UCA. In questo modo però il motto
"Sentire cum Ecclesia" veniva onorato solo nella sua
accezione più ovvia: consentire, non dissentire! Ma quel
motto portava da sé molto più avanti: non a una
sterile dialettica tra consen-so e dissenso, bensì alla
ricerca del 'senso'. Il passaggio, o, se proprio si vuole, la
conversione del vescovo Romero avvenne per il tramite di un approfondimento
del 'sentire' con la Chiesa. Così il Vescovo andava a raggiungere
quella radice autentica alla quale si era afferrata Teresa di
Lisieux (dottore della Chiesa!) quando diceva: "sento che
non mi sbaglio".
Approfondimento definitivo e veramente 'radicale' quello di Tere-sa
di Lisieux: "Nel cuore della Chiesa mia madre io sarò
l'amore". Approfondimento graduale, ma lineare e inflessibile
nella sua direzio-ne, nel vescovo Romero. Anche in lui c'è
il passaggio dagli ingranaggi della Chiesa al suo cuore pulsante,
dalla gerarchia della Chiesa alla genesi della Chiesa. Scriveva
in un suo 'Piano pastorale':
"Non
si deve intendere la fondazione della Chiesa in maniera legale,
giuridica, come se Cristo avesse dato una carta fondamentale ad
alcuni uomini tenendosi poi separato dagli uomini. L'origine della
Chiesa è assai più profonda. Cristo fondò
la Chiesa per restare egli stesso presente nella storia degli
uomini tramite il gruppo dei cristiani che formano la Chiesa.
La Chiesa è la carne nella quale Cristo concreta lungo
i secoli la propria vita e missione personale".
Credo che con questo testo Romero tocchi il punto dottrinalmente
più profondo del suo 'sentire con la Chiesa'. Da quella
profondità vengono le affermazioni, che sono ovvie quando
vengono prese in astratto, in generale, ma che diventano scandalose
quando sono de-dotte in pratica pastorale. Eccone una:
"Questo
è il pensiero fondamentale della mia predicazione. Niente
mi interessa come la vita umana... Il sangue e la morte vanno
molto più in là di ogni politica e toccano il cuore
stesso di Dio... Niente ha tanta impor-tanza per la Chiesa come
la vita umana, come la persona umana. Soprat-tutto la persona
dei poveri e oppressi, per i quali Gesù disse che tutto
ciò che viene fatto a essi viene fatto a lui".
È
chiaro che qui i poveri non sono considerati alla stregua di una
platea di bocche da sfamare, ma di bocche dalle quali imparare
la verità del Vangelo. Queste parole Romero le pronunziò
alte e chiare nel discorso in occasione del conferimento della
Laurea Honoris causa a Lovanio:
"Il
mondo dei poveri con caratteristiche sociali e politiche assai
concrete, ci insegna dove deve incarnarsi la Chiesa per evitare
la falsa universalizza-zione che termina sempre con la connivenza
coi potenti. Il mondo dei poveri ci insegna come deve essere l'amore
cristiano, che intende certa-mente la pace, ma che smaschera il
falso pacifismo, la rassegnazione e l'inattività. Crediamo
che questa sia la maniera di conservare l'identità e la
trascendenza stessa della Chiesa, perché in questa maniera
conservia-mo la fede in Dio.
Identità
e trascendenza: l'ultima omelia
Identità
e trascendenza. Queste due parole sono la bussola sulla quale
il Vescovo si orienta nella ricerca del 'senso' del "Sentire
cum Ecclesia". Cerchiamo di seguirlo in questa ricerca tenendo
sott'occhio in parti-colare le omelie della Quaresima del 1980
(che culminò con la sua morte). Quelle omelie suscitarono
vaste e opposte reazioni per qual-che cosa di inedito, di inusuale.
Chi mai fa attenzione allo schema delle omelie che il prete fa
in Chiesa? È già molto se la gente si porta via
qualche buon pensiero dall'insieme della predica. Qui invece è
proprio lo schema della predica a entusiasmare o a scandalizzare,
a suscitare ovazioni e proteste altissime. Lo schema delle omelie
quare-simali di Monsignor Romero era così stilato: la prima
parte era un commento alle letture bibliche, la seconda era costituita
da un elenco puntuale, dettagliato, anagrafico degli assassinati
della settimana e, quando era possibile, dei loro assassini o
mandanti. Questa scaletta di argomenti era per se stessa un segno
di contraddizione. C'era chi apprezzava la prima parte dell'omelia
(nella quale il Vescovo si dimo-strava un buon conoscitore della
Bibbia e dei biblisti) e magari si fosse fermato lì! C'era
invece chi era tutt'orecchi per la seconda parte e avrebbe magari
tagliato corto sulla prima.
Per il Vescovo invece il "Sentire cum Ecclesia" si traduceva
in quella concatenazione di argomenti solo apparentemente disparati.
Le due parti dell'omelia erano i due dadi di una sola giocata.
Nella prima parte dell'omelia c'era tutta la forza propulsiva
che poi andava a sfociare nella seconda parte. Vediamo più
da vicino.
Nella prima parte Romero metteva in luce la paziente opera di
Mosé nell'educare il popolo eletto, così che arrivasse
a essere tanto più popolo quanto più popolo di Dio
e tanto più popolo di Dio quanto più popolo. Applicata
al popolo salvadoregno (Monsignor Romero insiste-va volentieri
nel parallelismo tra il popolo d'Israele e il popolo del Salvador)
la lezione di Mosè girava attorno a quelle due parole-chiave:
identità e trascendenza. Quale storia meschina e a corto
respiro può fare il popolo del Salvador, se non è
popolo di Dio! Cogliamo qua e là dalle omelie:
"Quando
si perde di vista la trascendenza della lotta, tutto si fa consistere
in cose che invece sono addirittura sbagliate. Attenzione! Quelli
che lavorano oggi per la liberazione del popolo sappiano che senza
Dio non si può fare nulla e che con Dio anche la cosa più
insignificante è un apporto quando la si fa con buona volontà".
(Omelia della quinta domeni-ca di Quaresima)
E
nell'omelia del 13 gennaio 1980:
"Io
vorrei qui supplicare i leaders politici che parlano al microfono
di non gridare per il semplice fatto di avere davanti a sé
un microfono. La gente dice: Che cosa gli serve il microfono a
questo uomo?! C'è un proverbio che dice: "Non alzare
la voce, rafforza invece le tue ragioni".
Nell'omelia
del 27 gennaio 1980 affiora prepotente il suo "Sentire cum
Ecclesia".
"In
queste ore nelle quali tutto sembra relativo, nelle quali tutto
è confu-sione e niente è vero, come rimane solida
la parola del Vangelo. Il Vangelo dà una consistenza eterna
alla Chiesa. Perciò ripetiamo: la Chie-sa non vive di congiunture,
la Chiesa vive dell'eterna verità che si è realizzata
nel tempo".
Nella
stessa omelia.
"Io
non ho il minimo dubbio che tanto dolore e tanto sangue non abbiano
a dare un giorno un buon raccolto. Sono tempi duri, Dio vuole
che li comprendiamo tuttavia, che riusciamo a interpretare attraverso
essi i segni dei tempi".
Nell'omelia
della quinta domenica di Quaresima troviamo questa suggestiva
definizione della Chiesa: "La Chiesa è l'eterna pellegrina
della storia". Questo mistero di immanenza e di trascendenza
diventa particolarmente luminoso nella figura di Maria:
"Maria,
la Vergine, la serva di Jahweh, nel suo Magnificat canta il Dio
che libera gli uomini, i poveri; ma la dimensione politica di
questa liberazione esplode quando ella dice testualmente: 'Dio
rimanda a mani vuote i ricchi e ricolma di beni i poveri'. Maria
continua poi con una parola che noi potremmo dire insurrezionale:
'ha rovesciato i potenti dal trono'. Questa è la dimensione
politica della nostra fede: la visse Maria, la visse Gesù".
(Omelia del 17 febbraio 1980)
Tutto
questo è molto bello e importante. Ma se il vescovo Romero
si fosse fermato qui nessun tiratore scelto avrebbe mirato al
suo cuore quella sera del 24 marzo 1980 nella Cappella della Divina
Provviden-za. C'era da realizzare la seconda parte del progetto
di educazione di Mosè al popolo eletto: il popolo sarà
tanto più popolo di Dio quanto sarà popolo. Questo
fu l'aspetto ultimo e definitivo "Sentire cum Ecclesia"
da parte di Monsignor Romero. Qui infatti il 'sentire' ha relazione
immediata con la 'sensibilità'. In questo l'insegnamento
del vescovo Romero coincide con l'insegnamento del Papa. Parlando
nel Yankee Stadium nell'ottobre del 1979 Giovanni Paolo Il diceva:
"Il
pensiero sociale e la pratica sociale ispirata al Vangelo dovranno
sem-pre essere caratterizzati da una sensibilità per quelli
che più soffrono, per quelli che sono in estrema miseria,
per gli oppressi da mali fisici, mentali e morali che affliggono
l'umanità. Bisogna cercare le cause strutturali che provocano
i diversi tipi di povertà nel mondo".
E
il vescovo Romero:
"Se
insisto che c'è una repressione sempre crescente e che
sempre meno si reagisce di fronte a questo fatto, comprendetemi
bene: non voglio incitar-vi alla violenza. Coloro che mi hanno
capito così mi calunniano. Al contrario, quello che a me
interessa è domandare ai responsabili della escalation
della repressione di smettere dall'usare violenza per mantenere
il popolo nell'oppressione. E voglio pure convincere il popolo
a non perdere la sua sensibilità morale e la sua coscienza
critica". (Omelia della seconda domenica di Quaresima, 1980)
L'insensibilità
agisce come un corrosivo nel tessuto sociale ed eccle-siale. Ed
è esattamente a questo che tende il clima di terrore: che
sia nell'aria, ma non nominabile, non identificabile, anonimo,
senza i nomi degli assassini e delle vittime. Si arriva al punto
di cospargere i volti degli uccisi con liquidi corrosivi per impedirne
il riconoscimento e la denuncia al mondo di fuori. 'Cambiare i
connotati' ai singoli, farne una pedina nell'ingranaggio: questa
è la strategia di uno Stato che diventa signore e fa dell'uomo
uno schiavo.
Era appunto al fine di tener viva la sensibilità, di non
fare il callo attorno al cuore che il vescovo Romero si estendeva,
nella seconda parte dell'omelia, in un elenco dettagliato di nomi,
contro l'inqualifi-cabile strategia dei desaparecidos. In questo
compito di dare a ogni volto di ucciso il suo documento di identità
il Vescovo fu aiutato da donne come Marianela Garcia.
C'è
una domanda da fare, a conclusione. È mai possibile che
queste due realtà 'popolo di Dio' e 'popolo' si fondano
in una realtà unica?
Monsignor Romero lo crede e lo dimostra con alla mano l'esempio
di Maria.
"L'attitudine
di Maria - dice nell'omelia del 1980 sulle nozze di Cana - deve
esser la nostra attitudine di Chiesa, fiduciosa ma attiva [...].
Non si può ottenere un miracolo solo sperandolo da Dio,
senza porre da parte nostra tutto quello che è alla nostra
portata. Maria è la coniugazione meravigliosa della fede
e della attività".
Da
questa coniugazione nasce la gioia. Gioia più esplosiva
delle bom-be nei canti della Cattedrale. Gioia che risplende di
maggior luce sul corpo opaco che è la fede di molti cristiani
"così incolore, così smorta, così spenta"
(Omelia della Santa Famiglia 1980)
È
una gioia feconda, perché riempie i seminari di giovani:
"Abbon-dano le vocazioni fino al punto che non è possibile
riceverle nei nostri seminari". Ed erano cinque. Il Vescovo
apre le porte. "Dico a quelli che non hanno potuto entrare
in seminario: potete prepararvi anche nelle vostre case, e un
giorno presentarvi già pronti a ricevere l'ordina-zione".
Dipende molto da noi cristiani europei non essere un corpo opaco
sul quale per un attimo fiammeggia l'esempio del vescovo Romero,
ma rifletterne invece, nella fede e nella vita, il fermo e lontano
fulgore.
(La
Rivista del clero italiano, 5 maggio 2000)
================================================================
1.
Dalla prefazione di David M. Turoldo al libro di Levi A., Oscar
Arnulfo Romero, un vescovo fatto popolo, Brescia 1981.
2 Radius, Monsignor Romero, Milano 1993, p. 53.
3 "Il Regno. Attualità", 1990.
|